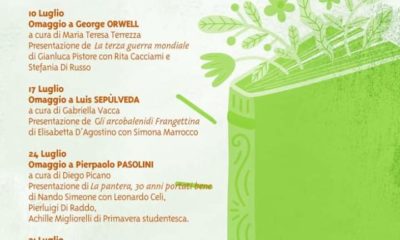All’indomani della Seconda guerra mondiale, l’Italia è un Paese ferito, diviso, ma non vinto. È il 1945, ottant’anni fa, quando il fotografo Federico Patellani, accompagnato dal pittore Carlo Pagani e dall’architetta Lina Bo, intraprende un lungo e toccante viaggio attraverso il Sud della penisola, attraversando città simbolo della distruzione: Cassino, Montecassino, Valmontone. Il loro obiettivo è uno solo: documentare, con lucidità e compassione, le conseguenze del conflitto sul tessuto umano e urbano della nazione.
Patellani intitola, descrive e sintetizza in tre articoli lo stato del nostro paese nell’immediato dopoguerra. Poche righe incisive scritte in francese, probabilmente pensate per una pubblicazione estera, che denunciano lo stato di vita nelle diverse zone geografiche italiane.
Due testi si riferiscono allo stato generale dell’Italia, mentre il terzo rientra – insieme al servizio su Valmontone – nel contesto dei viaggi in meridione; testi nei quali si riesce a leggere tra le righe la partecipazione con cui Patellani si butta a capofitto nel racconto dell’Italia da lui definita “ravagée”, devastata.
Patellani dà un titolo a questo reportage su Montecassino e Cassino: La vie dans le cimetière – La vita nel cimitero.
La vita nel cimitero
“Cassino e Montecassino sono un cimitero solo“, scrive Patellani. Le sue parole pesano come pietre. A valle, nella piana del Garigliano, 5.500 soldati anglosassoni sono caduti cercando di espugnare frontalmente il monte. Sui fianchi settentrionali, riposano 2.000 polacchi, morti nella manovra d’accerchiamento che consentì infine la conquista dell’abbazia. Le colline sono ricoperte dai tronchi neri degli ulivi bruciati. Il monastero di Montecassino, simbolo di spiritualità, è ora un rudere silenzioso. I monaci, sopravvissuti, vivono tra le macerie, raccolgono frammenti, ripuliscono altari, si aggirano come orsi in gabbia tra pietre e detriti, ostinati nel ricostruire un ordine spirituale nella devastazione materiale.
Le rovine abitate
Ma non tutto è desolazione. In mezzo ai ruderi, la vita si ostina a riaffermarsi. Un nuovo borgo è sorto: baracche in muratura a un piano, costruite in fretta per dare un tetto a chi ha perso tutto. Patellani osserva: “non è questa costruzione che conta, ai nostri occhi”. Conta, invece, l’umanità che abita le rovine, che si adatta, che sopravvive. Donne che trasportano mattoni sulla testa come fossero anfore, bambini che giocano tra le macerie, famiglie che si ricavano uno spazio tra ciò che resta di un primo piano. La vita torna, rabbiosa e ribelle, nel paesaggio polveroso.
Un documento per la memoria
I tre articoli in cui Patellani sintetizza la sua esperienza sono oggi considerati tra le testimonianze più importanti del primo dopoguerra italiano. Non è solo il valore documentaristico a renderli celebri, ma la loro capacità di far sentire la voce di un’Italia “ravagée”, devastata, ma non piegata. Tra le righe si legge l’empatia del fotografo-reporter, il suo gettarsi con passione nella narrazione di un Paese che, seppure sfigurato, non ha perso la sua anima.
Ottant’anni dopo, quel viaggio resta un monito e un simbolo: le macerie possono essere un inizio, se c’è chi ha il coraggio di raccontarle

 Scaffale6 anni ago
Scaffale6 anni ago
 news19 anni ago
news19 anni ago
 news17 anni ago
news17 anni ago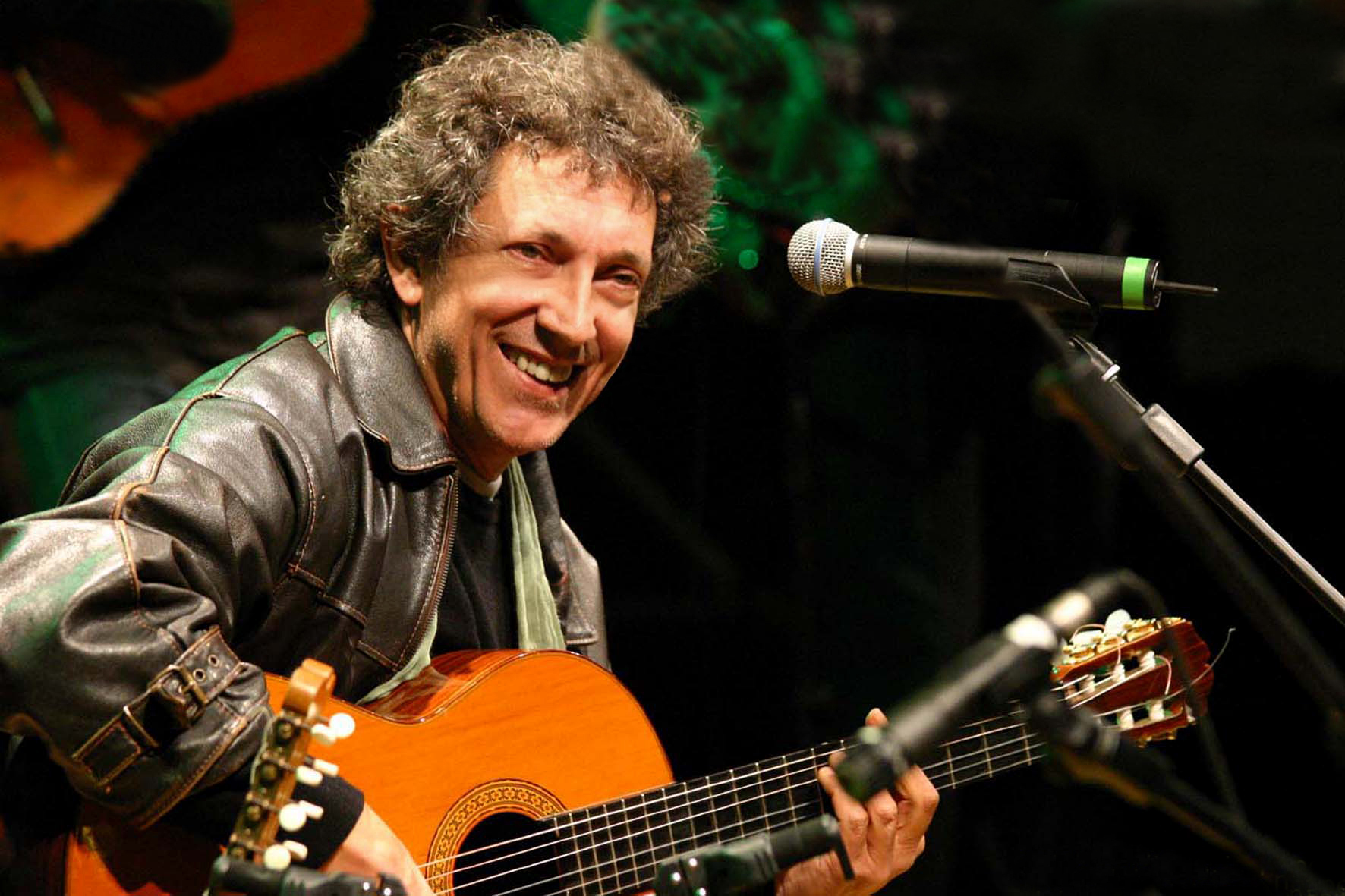
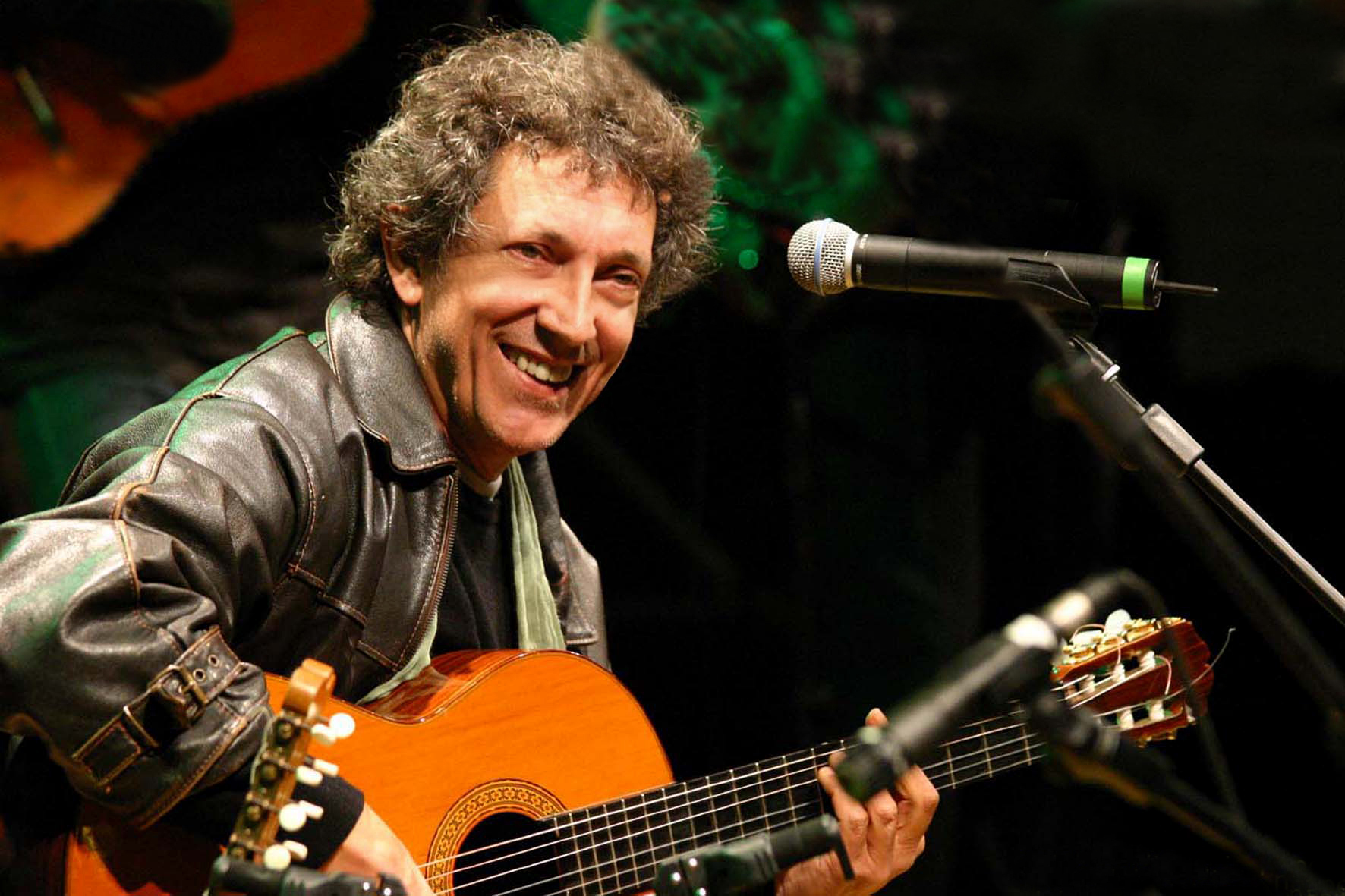 Musica15 anni ago
Musica15 anni ago
 news2 anni ago
news2 anni ago
 Itinerari19 anni ago
Itinerari19 anni ago